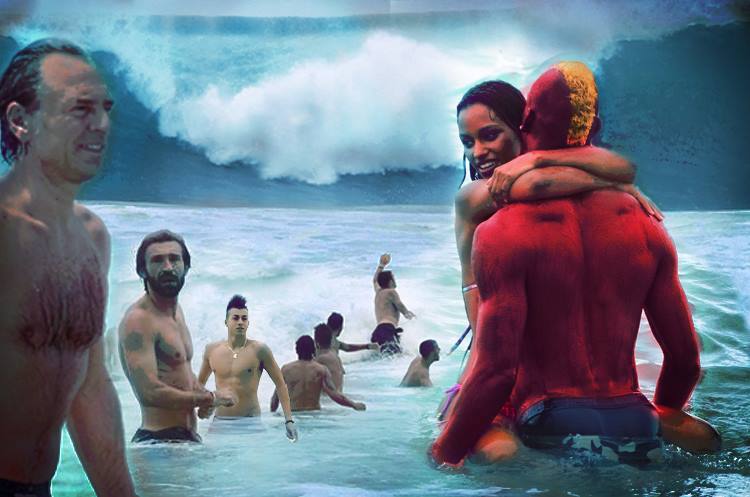Un uomo con i pantaloni aderenti e un giacchino imbottito e lucido è chino sul cofano aperto della propria macchina, nella neve. Un auto accosta. L’uomo si volta: ha i capelli all’indietro, intrisi di gel, e un sorriso un po’ ebete che mostra una ampia fessura fra gli incisivi. Parte l’inno di Mameli. “Ma, è Cesare Prandelli!”.
Il minuto scarso del cammeo dell’ex CT nel cinepanettone Natale a Cortina è emblematico di un personaggio la cui costruzione inizia all’incirca nel 2004, quando a causa della malattia della moglie si ritira dalla panchina della Roma. Davanti ai rari successi e ai frequenti fallimenti, giornalisti e pubblico hanno sempre, a partire da quell’evento, anteposto “l’uomo” all’allenatore. Si può dire oggi, rileggendo le tante, troppe interviste di Prandelli non attinenti allo sport di questi anni, che tale retorica non sia stata ridimensionata dall’allenatore, bensì alimentata, coltivata, più o meno premeditatamente usata come scudo davanti alle inevitabili critiche al suo lavoro, alla disarmante povertà delle sue idee. È dunque per questo che Prandelli non va trattato da allenatore, né da uomo. Per delinearne la parabola senza farsi confondere dalle chiacchiere, né perdersi in numeri e dettagli (non è l’assenza di trofei nella sua bacheca a determinarne la mediocrità), Prandelli va trattato da personaggio. Come tale, egli ha interpretato una parte, sostenuto una finzione sempre dominante rispetto alla quotidiana realtà di allenamenti, tattica e rapporti coi giocatori. Cose da piccoli uomini, da provinciali. Il coro di quello che spesso è suonato come un pianto greco, è stato in questi anni scandito da articoli forzatamente compiacenti o apologetici, da commenti di stima di spettatori e colleghi nazionali, “compatrioti” come li avrebbe definiti Prandelli stesso quando era CT.
Nonostante i fugaci e opportunistici afflati di patriottismo, uno dei pezzi forti del repertorio di Prandelli è sempre stato il biasimo del rapporto fra Paese e Pallone: nell’emanciparsi dal catenaccio per un non meglio precisato “calcio propositivo” e camaleontico, nell’abbandono di un tifo esasperato, polemico e rissoso, o in un maggiore attaccamento alla maglia (come quello degli uruguagi), Cesare sembrava credere che all’estero tutto fosse migliore. Deve essere stato allora ancora più amaro il boccone ingoiato prima in Turchia e poi in Spagna, dove i commentatori non hanno mantenuto lo stesso atteggiamento ossequioso verso i suoi lunghi monologhi da guru di un calcio moderno e illuminato, concentrandosi invece sulla pochezza dei suoi risultati. È difficile giudicare quanto il personaggio Prandelli sia stato l’origine o il palliativo per il male terminale che sembra aver colpito la carriera del Prandelli allenatore. È però evidente che il mondiale in Brasile, apice e baratro del suo calcio e forse del calcio in generale, ne abbia definitivamente sancito la diagnosi. La casetta Manaus, più tardi ridicolizzata dai giocatori a ogni intervista, è stata l’incubatrice del personaggio Prandelli e del virus che ne ha reso le squadre impotenti, sterili, schiacciate dagli avversari più mediocri. E lo stesso può dirsi dell’albergo di Mangaratiba, delle mogli in ritiro, dei calciatori rintronati da ore e ore di analisi video, sigarette, cocktail sulla spiaggia.
Il virus ha mietuto vittime quali Giuseppe Rossi (“volevamo raccontare una storia bella, una storia forte, ma non gli abbiamo mai promesso la convocazione”) oppure Mattia Destro (“Pin mi è testimone”). Ha anche probabilmente affossato per sempre la carriera di Mario Balotelli, prima sovraccaricato di responsabilità, poi scaricato al momento di abbandonare la nave, senza permettergli alcun contraddittorio. Un’altra “storia bella” del personaggio Prandelli è stata quella del codice etico: misterioso manuale di comportamento, citato per farsi bello con la stampa, ma dimenticato istantaneamente quando poco funzionale alle scelte di formazione. È difficile associare la parola etica alla carriera di un allenatore costellata di dichiarazioni contraddittorie e smentite delle sue società su obiettivi, contratti, scelte di mercato. Galatasaray e Valencia sono state le ultime tappe di una corsa a ostacoli il cui traguardo non era né il successo sportivo, né probabilmente quello economico, ma sempre di più quello di alimentare un’immagine, una fantasia, la cui incompiutezza è stata di volta in volta attribuita a presidenti, direttori sportivi, tifosi o calciatori.
È proprio in questo che Prandelli si dimostra più italiano di qualunque altro tecnico: non nel provincialismo o nella tattica, quanto nel costante tentativo di schivare responsabilità, manipolare le opinioni, scaricare barili. Non c’è catenaccio che tenga: il buonismo e la codardia da personaggio manzoniano di Prandelli sintetizzano quanto di più artefatto e surrettizio abbia prodotto il calcio (e non solo) nell’Italia degli ultimi decenni. Ed è di fronte a questa ruffianeria che la lunga lista di carogne del calcio italiano – Lippi, Capello, Conte, per citarne tre – appare come espressione autentica di un popolo che non ha mai avuto l’ardire di negare la centralità del calcio nella propria vita, né di sputare nel piatto nel quale ha mangiato.